 L’attrazione della letteratura per la fotografia ha una storia quasi bisecolare. Che diventi metafora per il suo aspetto tecnico, o sia vista come dettaglio metonimico di un tutto misterioso, l’immagine fotografica dischiude le porte di un altrove di grande fascinazione per lo scrittore. Il saggio L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura (2011) ripercorre attraverso esempi e teorie questa ricca relazione.
L’attrazione della letteratura per la fotografia ha una storia quasi bisecolare. Che diventi metafora per il suo aspetto tecnico, o sia vista come dettaglio metonimico di un tutto misterioso, l’immagine fotografica dischiude le porte di un altrove di grande fascinazione per lo scrittore. Il saggio L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura (2011) ripercorre attraverso esempi e teorie questa ricca relazione.
Intervista a Remo Ceserani
«Con il piacere è come con le fotografie. Quello che si realizza in presenza dell’essere amato non è che un cliché negativo, lo si sviluppa dopo, una volta arrivati a casa, quando si ritrova a propria disposizione quell’interiore camera oscura il cui ingresso è interdetto finché si sta con la gente».
Partiamo da questa citazione da All’ombra delle fanciulle in fiore di Proust – una citazione nella quale la fotografia è usata come metafora, come lei dice «vagamente freudiana» – per parlare del ruolo della fotografia nella letteratura. In Proust la fotografia è molto presente. In che modo?
 È presente in tanti modi diversi, tutti ispirati da una forte attrazione, un vero e proprio fascino, per la tecnologia fotografica: anzitutto come ritratto di persone conosciute e amate (famosi i passi sulla fotografia della nonna di Marcel, che rielaborano i temi della memoria e della morte), poi come strumento di ricostruzione di luoghi ed eventi del passato, poi come spinta a numerose applicazioni metaforiche, del tempo, della memoria, del procedimento stesso della scrittura. Il passo che lei cita si collega curiosamente, anche se non può esserci un rapporto diretto, con una pagina di Freud in Der Mann Moses (1934-38), là dove Freud, per spiegare il fenomeno della rimozione dei ricordi traumatici dell’infanzia, ricorre all’analogia con la tecnica fotografica e cioè con quella della lastra fotografica che riceve un’immagine, può tenerla dentro di sé a lungo e può essere sviluppata in futuro, in qualsiasi momento: «Ciò che i bambini di due anni hanno vissuto e non compreso, possono benissimo non ricordarlo mai più se non in sogno».
È presente in tanti modi diversi, tutti ispirati da una forte attrazione, un vero e proprio fascino, per la tecnologia fotografica: anzitutto come ritratto di persone conosciute e amate (famosi i passi sulla fotografia della nonna di Marcel, che rielaborano i temi della memoria e della morte), poi come strumento di ricostruzione di luoghi ed eventi del passato, poi come spinta a numerose applicazioni metaforiche, del tempo, della memoria, del procedimento stesso della scrittura. Il passo che lei cita si collega curiosamente, anche se non può esserci un rapporto diretto, con una pagina di Freud in Der Mann Moses (1934-38), là dove Freud, per spiegare il fenomeno della rimozione dei ricordi traumatici dell’infanzia, ricorre all’analogia con la tecnica fotografica e cioè con quella della lastra fotografica che riceve un’immagine, può tenerla dentro di sé a lungo e può essere sviluppata in futuro, in qualsiasi momento: «Ciò che i bambini di due anni hanno vissuto e non compreso, possono benissimo non ricordarlo mai più se non in sogno».
Più in generale che rapporto c’è tra fotografia e letteratura? Cortázar dice «il romanzo e il racconto si possono paragonare al cinema e alla fotografia», nel senso che sia il fotografo che lo scrittore di racconti scelgono un’immagine significativa che funzioni come una specie di ‘apertura’ verso qualcosa che va molto oltre la foto o il racconto. E’ il punctum di cui parla Roland Barthes?
Il rapporto è anzitutto tematico: l’arrivo della fotografia, come ho mostrato con numerosi esempi, ha fortemente colpito gli scrittori, suscitando entusiasmo e inquietudine; di qui la presenza di molte fotografie in libri di memorie, saggi, romanzi, ma anche in molte poesie (Apollinaire, Larkin, Atwood, Rilke, Andrade). Ma il rapporto, come dimostra l’acuta osservazione di Cortázar, riguarda anche il procedimento della rappresentazione e della narrazione. Mi fa piacere che lei abbia colto l’importanza di quella citazione e l’abbia collegata con il momento di apertura improvvisa, per chi guarda una fotografia, verso un aspetto importante e inatteso dell’esperienza (e della memoria), che Barthes ha definito il punctum. La frase di Cortázar serve anche a ribadire non solo la distinzione di statuto narrativo fra romanzo e racconto, ma anche quella tra cinema e fotografia, che troppo spesso vengono posti sullo stesso piano: la fotografia cattura un istante, un momento solo e immobile, della vita; il cinema, che è arte distesamente narrativa, cerca della vita di cogliere il movimento e le trasformazioni.
Nel 1838 nasce il dagherrotipo. Che sconvolge non solo la pittura ma anche la letteratura. Quando è apparsa la fotografia nell’immaginario dello scrittore?
Il fenomeno è straordinariamente precoce. Fra i primi a reagire (con atteggiamenti non sempre entusiastici) gli scrittori francesi e, curiosamente (ma forse comprensibilmente), quelli americani del movimento trascendentalista: Emerson, Holmes, Hawthorne e Thoreau. Un racconto di Hawhorne, The Birth-mark (1843) e un suo romanzo: The House of the Seven Gables (1851) affrontano già gli aspetti inquietanti della nuova tecnologia. Ho cercato di approfondire il rapporto dei trascendentalisti americani con la fotografia in un saggio intitolato Magnetismo, mesmerismo, elettricità, fotografia in un ‘romance’ di N. Hawthorne, pubblicato nella raccolta di studi per Roberto Bigazzi: I colori della narrativa, a cura di A. Matucci e S. Micali, Roma, Aracne, 2010, pp. 143-11.

‘Non guarda nulla;
trattiene dentro di sé
il suo amore e la sua paura:
ecco, lo Sguardo è questo’.
La Chambre claire, Roland Barthes (foto André Kertész)
Barthes ha scritto che la fotografia «non sa dire ciò che dà a vedere». È qualcosa che «è stato», qualcosa di «intrattabile». Tutto questo ha a che fare, nella trasposizione letteraria, con la morte?
La cosa interessante, nella teoria di Barthes, è che per lui, fin dai primi scritti sull’argomento e via via in modo più netto sino alla Chambre claire, la caratteristica principale della fotografia è la sua «presenza» ontologica, e non la sua funzione di comunicazione semiotica. Questa posizione ha fatto gridare alcuni dei più rigidi sostenitori dello strutturalismo e della semiotica, come per esempio Jonathan Culler, al tradimento (Culler ha parlato di «ritorno a posizioni alquanto regressive, presemiotiche»). È questa qualità ontologica che conferisce alla fotografia il suo aspetto perturbante e la collega con il lutto, la malinconia e la morte. Ne parla Barthes a proposito della fotografia di uno scolaretto di nome Ernest ritratto da Kertész, che «induce a far mente locale, a considerare la vita, la morte, l’inesorabile estinguersi delle generazioni», e anche a domandarsi che ne è stato di quel ragazzino (morto in guerra? finito nei lager nazisti?). Della stessa fotografia parla W. G. Sebald, che anche lui si chiede cosa è avvenuto di quel bambino e poi attribuisce alla fotografia la capacità di «esercitare una forza d’attrazione su chi la guarda, e in modo stupefacente (e mostruoso) strapparlo, per così dire, al mondo reale per trasportarlo in un mondo irreale, un mondo di cui non sa esattamente come sia costituito ma si sente che è lì. […] C’è una forma secondaria di esistenza, una forma che è coordinata con la nostra, è superiore o subordinata alla nostra. Le persone che scompaiono dalla vita si aggirano furtivamente in qualche luogo di quest’altra vita». Di questo aspetto ontologico della fotografia era perfettamente consapevole anche Walter Benjamin. Proprio ispirandosi ad alcuni concetti espressi negli aforismi benjaminiani di Zentralpark (1938), secondo cui il ricordo altro non è che una «reliquia secolarizzata», derivata dal cadavere, dall’esperienza defunta e definita, eufemisticamente, ‘esperienza contingente’, uno studioso americano che insegna a Princeton, Eduardo Cadava, in un bel libro intitolato Words of Light. Theses on the Photography of History (1997), ha dichiarato che la fotografia è «il cadavere di un’esperienza» e ha aggiunto che «la morte, sia la parola che l’evento, è una fotografia che fotografa se stessa — una fotografia che si pone nel punto di sospensione fra la realtà e il suo referente».
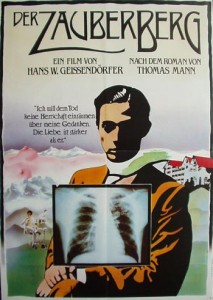 A proposito della morte, una famosa fotografia ‘letteraria’ è quella, nella Montagna incantata di Thomas Mann, dei raggi X del torace della malata di tubercolosi Claudia Chauchat, custodita come un feticcio dal protagonista di lei invaghito, Hans Castorp. La fotografia come immagine segreta?
A proposito della morte, una famosa fotografia ‘letteraria’ è quella, nella Montagna incantata di Thomas Mann, dei raggi X del torace della malata di tubercolosi Claudia Chauchat, custodita come un feticcio dal protagonista di lei invaghito, Hans Castorp. La fotografia come immagine segreta?
L’idea dell’immagine segreta del corpo umano offerta dai raggi X, oltre che in quel passo famoso della Montagna incantata, compare anche, in un contesto diverso, in una pagina del Côté de Guermantes di Proust, dove rappresenta, metaforicamente, la possibilità di decifrare motivazioni e comportamenti misteriosi e complicati degli esseri umani. È l’antica aspirazione a penetrare nei luoghi segreti della nostra mente (o «anima», come spesso la si chiama), la stessa che spingeva, nel romanzo di García Márquez, Cien años de soledad (1967) il vecchio José Arcadio Bendìa a usare la nuova prodigiosa invenzione portata a Macondo dallo zingaro Melquíades per fotografare finalmente Dio e dare così una prova scientifica della sua esistenza. Ma ora che la tecnologia moderna consente ai medici di entrare con le piccole telecamere negli organi interni del nostro corpo e ai neuro-scienziati di riprodurre al computer le innumerevoli cellule che costituiscono il nostro cervello, ci vorrebbero un Proust o un García Márquez per studiare le conseguenze di questo nuovo uso della fotografia.
Tra gli scrittori italiani si sofferma su Italo Calvino e Antonio Tabucchi. Che rapporto hanno i loro mondi narrativi con la fotografia?
Ho dedicato un bel po’ di pagine a Calvino e a Tabucchi, in particolare alle analisi sospettose e alle riflessioni filosofiche del primo nel racconto L’avventura di un fotografo (1970) e alla frequentissima presenza della fotografia nelle opere del secondo, in particolare nel romanzo ontologico Il filo dell’orizzonte (1986). Ma ci sono, nel libro, parecchie altre presenze italiane: da Vittorio Imbriani a Giovanni Verga, da Lalla Romano a Danilo Mainardi. E c’è l’analisi attenta di un romanzo poco noto di Paolo Maurensig, che ha per protagonista un fotografo: L’ombra e la meridiana (1998).
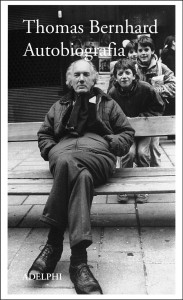 L’ultimo capitolo del suo saggio è intitolato «Manipolazioni, ingrandimenti, dettagli, decifrazioni». In particolare nel suo ultimo romanzo, Estinzione, Thomas Bernhard sostiene che la fotografia ha una natura mistificante e falsificatoria. In che senso lo sostiene?
L’ultimo capitolo del suo saggio è intitolato «Manipolazioni, ingrandimenti, dettagli, decifrazioni». In particolare nel suo ultimo romanzo, Estinzione, Thomas Bernhard sostiene che la fotografia ha una natura mistificante e falsificatoria. In che senso lo sostiene?
Per la verità Bernhard, in Auslöschung (1986) mette quei terribili sfoghi e quelle espressioni di odio verso le qualità mistificatorie della fotografia in bocca al suo personaggio, Franz Josef Murau, il quale si scaglia, attraverso le fotografie, contro i suoi genitori, i loro comportamenti conformisti e le loro idee parafasciste. Anche se non è corretto attribuire immediatamente le opinioni di un personaggio di romanzo al suo autore, non andiamo molto lontano dal vero se pensiamo che anche a Bernhard il proliferare di fotografie nel nostro mondo borghese, il culto della foto-ritratto da esibire sui comodini nelle stanze da letto o sui caminetti nei salotti non piaceva per niente. In questo egli era erede di un atteggiamento verso l’uso sociale della fotografia 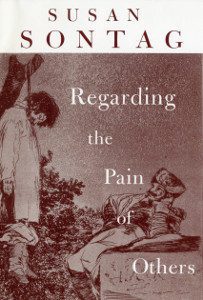 che è stato anche di Walter Benjamin, di Susan Sontag e di Roland Barthes. La Sontag, in particolare, pur avendo (come del resto Benjamin e Barthes) sempre prestato molta attenzione alla fotografia, scritto di mostre fotografiche e presentato antologie di grandi fotografie del passato, ha costantemente messo in guardia contro l’eccessiva presenza dell’immagine fotografica nelle nostre società e, nell’ultimo libro da lei scritto Regarding the Pain of Others (2003) ha dato voce a una potente denuncia contro l’uso indiscriminato e morboso della fotografia nei reportages delle guerre moderne.
che è stato anche di Walter Benjamin, di Susan Sontag e di Roland Barthes. La Sontag, in particolare, pur avendo (come del resto Benjamin e Barthes) sempre prestato molta attenzione alla fotografia, scritto di mostre fotografiche e presentato antologie di grandi fotografie del passato, ha costantemente messo in guardia contro l’eccessiva presenza dell’immagine fotografica nelle nostre società e, nell’ultimo libro da lei scritto Regarding the Pain of Others (2003) ha dato voce a una potente denuncia contro l’uso indiscriminato e morboso della fotografia nei reportages delle guerre moderne.
Con il digitale la fotografia è diventata un linguaggio più pervasivo e duttile di quanto sia mai stato. Secondo lei che effetti ha sulla letteratura questa diffusa ‘democrazia’ dell’immagine?
Mi piacerebbe sentire cosa potrebbero pensare Benjamin, Sontag, Calvino o Bernhard di questa straordinaria invasione, non solo della nostra vita quotidiana, ma del nostro immaginario e della nostra capacità di assorbire e immagazzinare immagini provocata dalla rivoluzione digitale. Temo che non tutti accetterebbero il termine ‘democrazia’. La discussione si sposterebbe inevitabilmente sul giudizio da dare di Facebook, You Tube, Twitter e simili. Per ora mi pare che gli scrittori, di fronte a un tale grandioso fenomeno, siano disorientati. Non conosco testi di narrativa che ne affrontino veramente tutte le implicazioni.
(intervista del gennaio 2012 per il blog Libri di Rainews)
